
Quadri raffiguranti il gioco della mosca cieca
di Grazia Merelli
La mosca cieca è un gioco classico, tramandato nel tempo di generazione in generazione; vi si giocava già nell’antichità: infatti lo cita Macrobio con l’appellativo di “mosca di rame”.
Il gioco è stato rappresentato spesso nell’arte, soprattutto nelle scene di vita quotidiana. Sebbene sia stata raffigurata anche prima, è nel Settecento che la mosca cieca diviene un soggetto popolare in pittura, soprattutto in ambito francese. A quel tempo infatti si era affermata una pittura che celebrava i fasti della nobiltà, descrivendone il lusso e divertimenti. L’arte pertanto rispecchiava la vita di corte dell’epoca, descrivendola con le pennellate leggere ed eleganti del gusto rococò.
Il clima festoso e libertino che caratterizzava la corte francese si era affermato con la reggenza di Filippo II Duca d’Orleans e permase anche durante il regno di Luigi XV. I nobili trascorrevano allora le giornate nei giardini, dilettandosi con diversi passatempi.
Nell’ambito di una corte frivola dedita soprattutto all’arte del corteggiamento, il successo della mosca cieca era dovuto al fatto ch’essa si prestava ad essere usata come un gioco di seduzione, per la facile allusione alla cecità dell’amore.

Il legame con la tematica amorosa era presente già in una Mosca cieca di Francois Boucher, primo pittore di corte di Luigi XV. Il dipinto, realizzato nel 1733 e appartenente all’Indianapolis Museum of Art, ha un carattere classicheggiante; vi compaiono infatti cinque putti che stanno giocando a mosca cieca all’aperto.

A differenza di Boucher, gli altri pittori francesi del tempo hanno raffigurato per lo più un gruppo di giovani che giocano immersi una natura rigogliosa. Ne è un esempio Le coline-maillard di Jean-Baptiste Joseph Pater, conservato nella Wallace Collection di Londra e realizzato negli anni 1730-1733; nel quadro un gruppo di giovani sta giocando a mosca cieca; il ragazzo che guarda verso la scollatura della fanciulla bendata mostra il clima licenzioso della scena, cui contribuiscono anche le movenze e gli sguardi ammiccanti dei presenti. Le pennellate leggere e sfumate di Pater, erede del grande Watteau, conferiscono al dipinto un’atmosfera quasi rarefatta.

Il richiamo al gioco della seduzione è ancora più evidente ne La mosca cieca di Jean Honoré Fragonard, conservata nel Museo d’arte di Toledo. Qui infatti il gioco di gruppo ha lasciato il posto a un sensuale gioco a due; completano la scena due putti vestiti che, insieme alle splendide rose, rimandano alla tematica amorosa. L’opera testimonia il gusto rococò per la scena galante immersa nella natura.


Fragonard si è cimentato anche altre volte nel tema; la Mosca cieca della National Gallery di Washington è un quadro di paesaggio, facente parte di una serie di quattro quadri dedicati ai passatempi della nobiltà. Qui il gioco si svolge in un elegante giardino, con tanto di fontana e cascata. Mentre a destra si svolge un banchetto, sulla sinistra alcuni giovani si stanno cimentando nel gioco. Ancora una volta è una fanciulla a portare la benda, circondata dai partecipanti al gioco che fuggono qua e là per non farsi toccare.

Si svolge invece all’interno una Mosca cieca di Nicolas Lancret (1690-1743), conservata nel Museo Nazionale di Stoccolma; l’artista ha ambientato la scena in una grande sala; stavolta è un uomo ad essere bendato e a lui si avvicina un’avvenente ragazza, sfiorandogli il viso con una piuma. Sempre un uomo porta la benda in un altro dipinto di Lancret, appartenente a una collezione privata, dove una corda rischia di far cadere l’ignaro protagonista.

Dunque nelle opere degli artisti francesi la mosca cieca appare come un gioco di seduzione, adatto ad una corte frivola e dedita ai divertimenti. Il fascino di questi quadri risiede proprio nell’atmosfera leggera e raffinata che sanno evocare. Quel clima sarebbe poi tramontato di lì a poco sotto i colpi dell’Illuminismo.
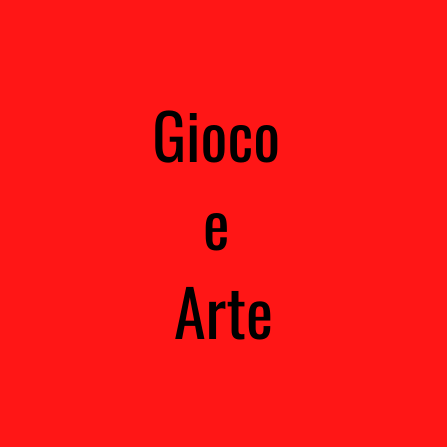



Lascia un commento